GLI EFFETTI DELL’ INQUINAMENTO SULLE PIANTE
GLI EFFETTI DELL’ INQUINAMENTO SULLE PIANTE |
DESCRIZIONE DEL FENOMENO
L’inquinamento atmosferico
è uno dei principali problemi ambientali in Europa. L’effetto serra ,
l’assottigliamento della fascia di ozono, le piogge acide sono argomenti che ormai
vengono trattati da tutti i mezzi di informazione. Pero’ la soluzione a tali problemi
ambientali è ancora lontana.
EFFETTI SUGLI ORGANISMI VEGETALI
 Le piante sono tra gli
organismi più a rischio a causa dell’inquinamento atmosferico e marino. In
particolare sono molto sensibili all’inquinamento atmosferico le graminacee (
importanti per l’alimentazione), tabacco, erba medica, e loglio. Ecco perché sono
usate come bio-indicatori ambientali.Inoltre sono stati riscontrati notevoli effetti
nocivi anche sulle piante ad alto fusto quali l’abete bianco a partire dagli anni
settanta ,l’abete rosso , il pino e il faggio fin dal 1982 e il castagno , la
roverella , il tasso , il tiglio , il noce , il salice , il pino marittimo , l’acero
, il ciliegio e i frassini a partire dal 1984. Queste piante sono presenti anche a Vallombrosa e vedremo più avanti gli effetti
dell’inquinamento su tali organismi.Tra gli effetti dell’inquinamento ci sono
quelli causati dall’ozono, il cui danno tipico sulle piante è costituito da piccoli
puntini necrotici di colore che va dal bianco al nero.Mentre si è potuto costatare che
attraverso l’impiego di piogge acide simulate le deposizioni acide possono avere
effetti diretti ed indiretti sulla vegetazione.
Le piante sono tra gli
organismi più a rischio a causa dell’inquinamento atmosferico e marino. In
particolare sono molto sensibili all’inquinamento atmosferico le graminacee (
importanti per l’alimentazione), tabacco, erba medica, e loglio. Ecco perché sono
usate come bio-indicatori ambientali.Inoltre sono stati riscontrati notevoli effetti
nocivi anche sulle piante ad alto fusto quali l’abete bianco a partire dagli anni
settanta ,l’abete rosso , il pino e il faggio fin dal 1982 e il castagno , la
roverella , il tasso , il tiglio , il noce , il salice , il pino marittimo , l’acero
, il ciliegio e i frassini a partire dal 1984. Queste piante sono presenti anche a Vallombrosa e vedremo più avanti gli effetti
dell’inquinamento su tali organismi.Tra gli effetti dell’inquinamento ci sono
quelli causati dall’ozono, il cui danno tipico sulle piante è costituito da piccoli
puntini necrotici di colore che va dal bianco al nero.Mentre si è potuto costatare che
attraverso l’impiego di piogge acide simulate le deposizioni acide possono avere
effetti diretti ed indiretti sulla vegetazione.
EFFETTI DIRETTI
Ad esempio si sono verificati danni alle strutture superficiali di protezione
come le cuticole , facilitazione agli attacchi parassitari, e soprattutto un notevole
disturbo del normale metabolismo e dei processi di crescita con diminuzione della
fotosintesi, respirazione alterata e precoce senescenza delle foglie e anche una
interferenza nei processi di riproduzione sessuata e diminuzione della vitalità del
polline.
EFFETTI INDIRETTI
Tra i tanti effetti, i più importanti sono un aumento notevole della
suscettibilità alla siccità e ad altri fattori ambientali avversi e un accelerato
lisciviamento delle sostanze dagli organi fogliari. Nel febbraio 1984 in Toscana fu fatta
un’analisi sulla qualità delle piogge. Furono poste alcune stazioni di campionamento
( una a Firenze periferia e nel centro , a San Rossore e a Vallombrosa in località
scoperta e al riparo di un ‘abetina).La stazione di Vallombrosa è posta sulla
dorsale del Pratomagno che divide il Casentino dal Valdarno superiore e precisamente
all’interno della Riserva Biogenetica gestita dal Corpo Forestale dello Stato. A
Vallombrosa si riscontrò che tutte le piogge avevano un pH intorno a 4 contrariamente a
quanto ci si aspettava essendo una zona montana e ciò costituisce un ulteriore indice del
trasporto di inquinanti da regioni assai lontane. A questo valore di pH e ad un alto
contenuto di alluminio nelle radici esse si riducono enormemente, si atrofizzano ed in
qualche caso muoiono.In generale l’acidità risulta superiore di 10 volte a quella
normale , in quanto la scala del pH ha un andamento logaritmico. Un’acidità maggiore
è stata riscontrata nelle nebbie a causa dei venti da ovest che trasportano sodio , cloro
e magnesio e sostanze tensioattive ( detersivi ) veicolati dall’aerosol marino.
IL
BIOMONITORAGGIO
In questi ultimi anni è stato
trovato un nuovo modo per controllare le dinamiche spazio-temporali dell’inquinamento
atmosferico. Nel periodo 95-97 la commissione europea ha dato il via ad un progetto pilota
sull’uso di piante come bio-indicatori a cui hanno partecipato otto città europee
tra cui Firenze. Il progetto sviluppato a Firenze ha permesso il monitoraggio di ozono,
metalli in traccia (Pb, Cr, Fe e Ni) e cloro.
Il monitoraggio di inquinamento, cioè la prima misura nel tempo e nello spazio della loro
presenza, costituisce la stadio iniziale dello studio dei loro effetti sull’ambiente.
Le apparecchiature per il monitoraggio vengono istallate nel centro urbano ,dal momento
che necessitano di energia elettrica e i costi di manutenzione sono elevati. Inoltre le
misurazioni che esse forniscono anche se sono precise ed affidabili , hanno un carattere
puntiforme nel tempo e nello spazio .
A causa di queste motivazioni le misure risultano non sempre adeguate a soddisfare
l’esigenza di effettuare valutazioni sull’inquinamento atmosferico in ampi
territori e per periodi di tempo lunghi. Ma siccome gli effetti sugli organismi viventi
sono influenzati da fenomeni non rilevabili con queste apparecchiature è nata la
necessità di usare dei test biologici ( biomonitoraggio) che considerino i parametri
legati agli organismi viventi (bio-indicatori). I bio-indicatori sono molto sensibili
all’effetto sinergico dei diversi inquinanti presenti nell’atmosfera, e ci
permettono di studiare una porzione molto ampia di territorio.
A Firenze, infatti, è stato fatto il biomonitoraggio previsto nel progetto pilota con
indicatori biologici che permette di ottenere informazioni sulla situazione ambientale di
vaste aree geografiche con moderate spese.
 I migliori bio-indicatori della qualità
dell’aria sono considerati i licheni epifiti
I migliori bio-indicatori della qualità
dell’aria sono considerati i licheni epifiti
( cioè quelli che vivono sulla corteccia degli alberi ) in virtù di alcune peculiarità
fisiologiche ed ecologiche che li contraddistinguono:
- lungo ciclo vitale e scarsa mobilità
- sono molto sensibili agli agenti inquinanti
- ampia diffusione nel territorio in esame
- dipendono per la loro nutrizione dall’atmosfera assorbendo cationi dall’acqua piovana e dall’umidità atmosferica
- sono privi di stomi e cuticola e perciò capaci di assorbire sostanze attraverso tutta la superficie del tallo
- hanno un ciclo biologico lungo ed un lento accrescimento ed incapacità di eliminare parti vecchie o contaminate
- la loro resistenza alle basse temperature ed allo stress idrico permette loro di essere attivi anche nei periodi invernali ed estivi, quando i livelli di inquinamento atmosferico sono in genere più elevati.
 Nel 1866, infatti, si usarono per la prima volta i licheni come
bio-indicatori ambientali. La loro scomparsa in alcune aree extraurbane fu indice di una
contaminazione dell’atmosfera da parte di un certo numero di inquinanti (specie SO2)
e si verificarono alcune conseguenze tra le quali : riduzione della fotosintesi, della
fertilità e del numero totale di specie, alterazione della comunità lichenica e della
forma e del colore del tallo.Lo scopo dello studio è determinare la presenza
nell’aria di uno specifico inquinante quale ozono e metalli in tracce di origine
antropica cioè causati dalle attività industriali, Questi bio-indicatori in generale si
possono distinguere in piante indicatrici ed accumulatrici. Le piante indicatrici
reagiscono alla presenza di una certa concentrazione d’inquinante per questo si
formano danni visibili che possono andare da variazioni del loro sviluppo, fino alla
clorosi (mancanza di clorofilla) oppure fino alla necrosi (lesioni del mesofillo
fogliare). La pianta indicatrice usata a Firenze è stato la Nicotiana tabacum. Invece le
piante accumulatrici servono per accumulare alcuni inquinanti, quali fluoruri e metalli
pesanti. A Firenze la pianta accumulatrice usata è stata la Lolium multiflorum una comune
graminacea.
Nel 1866, infatti, si usarono per la prima volta i licheni come
bio-indicatori ambientali. La loro scomparsa in alcune aree extraurbane fu indice di una
contaminazione dell’atmosfera da parte di un certo numero di inquinanti (specie SO2)
e si verificarono alcune conseguenze tra le quali : riduzione della fotosintesi, della
fertilità e del numero totale di specie, alterazione della comunità lichenica e della
forma e del colore del tallo.Lo scopo dello studio è determinare la presenza
nell’aria di uno specifico inquinante quale ozono e metalli in tracce di origine
antropica cioè causati dalle attività industriali, Questi bio-indicatori in generale si
possono distinguere in piante indicatrici ed accumulatrici. Le piante indicatrici
reagiscono alla presenza di una certa concentrazione d’inquinante per questo si
formano danni visibili che possono andare da variazioni del loro sviluppo, fino alla
clorosi (mancanza di clorofilla) oppure fino alla necrosi (lesioni del mesofillo
fogliare). La pianta indicatrice usata a Firenze è stato la Nicotiana tabacum. Invece le
piante accumulatrici servono per accumulare alcuni inquinanti, quali fluoruri e metalli
pesanti. A Firenze la pianta accumulatrice usata è stata la Lolium multiflorum una comune
graminacea.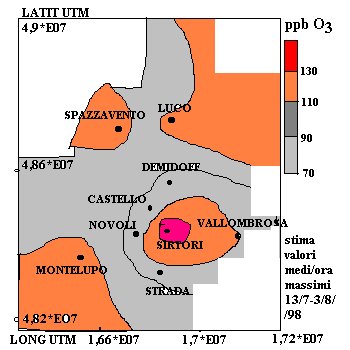
A Firenze sono state installate dieci stazioni di
monitoraggio. Ogni stazione è stata equipaggiata con piante bioindicatrici di ozono (5
Nicotiana Tabacum L Bel W3 e 3 Tabacum L Bel B), di anidride solforica ( Medicago Sativa
L) e bioaccumulatrici (Lolium multiflorum). Ogni set di piante è rimasto in campo per
quattro settimane e poi è stato sostituito con uno nuovo. Il periodo esaminato è stato
tra il 23 maggio e il 16 ottobre del '96. Le stazioni sono state visitate settimanalmente
per la valutazione del danno fogliare. Il danno tipico da ozono è stato valutato secondo
categorie percentuali codificati da zero ( nessun danno ) a 8 (>- 40% della superficie
della foglia coperta da necrosi) . Poi dai dati di danno fogliare è stato calcolato
l'indice di danno sfogliare. I sintomi attribuibili ad ozono si sono manifestati sulle
piante ozono sensibili Bel W3 dopo 48-72 ore dall'esposizione all'aria ambientale. Le
concentrazioni di ozono sono state misurate poi da 3 analizzatori automatici in
prossimità dei siti di Novoli, Settignano e via di Bastioni. Il valore più elevato è
stato registrato a Settignano (ca. 390 g/m3). Il biomonitoraggio è continuato
negli anni seguenti: è stato studiato un modello matematico predittivo di concentrazione
di ozono, nel 1998, che,combinando i dati dei bioindicatori con quelli dei
computers, ha evidenziato le zone di attenzione più importanti (vedi tabella a
lato - da Rapporto sull'ambiente Prov. FI '99).
Per i metalli pesanti invece sono usate le piante
accumulatrici. In particolare è stata scelta una graminacea, la Lolium multiflorum. I
metalli pesanti sono metalli quali Cadmio, Mercurio, Zinco, Cromo, Nichel e Manganese.
Tali metalli vengono prodotti dall'incenerimento dei rifiuti solidi urbani e varie
attività industriali. Il piombo invece deriva dalla combustione di carburanti contenenti
additivi al piombo. Esso è molto tossico per gli animali che assumono piombo in forma
diretta ed indiretta. Infatti, essendo una graminacea viene ingerita dagli animali che
rimangono avvelenati in quanto tale pianta accumula i metalli pesanti.Oltre ad ingerirli
però i metalli possono essere anche respirati sotto forma di polveri
atmosferiche.Mensilmente è stato effettuato il prelievo dei campioni di Lolium.
Successivamente sono stati aggiunti a 0,7 g di peso fresco del campione (precedentemente
sminuzzato) 1,5 ml di acido nitrico concentrato e 0,5 ml di acqua ossigenata.Poi
l'omogenato è stato disgregato con l'apparecchio a microonde e portato a 15 ml con acqua
bidistillata. A questo punto si è fatto l'analisi.
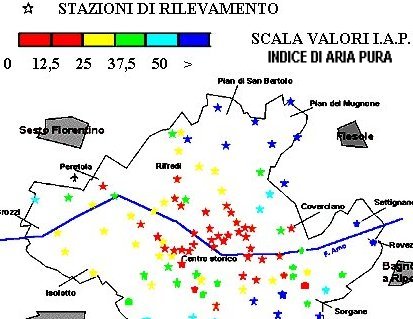 Dai risultati ottenuti si può dire che la maggiore
concentrazione dei metalli si ha nel centro cittadino. Tale concentrazione va da 6 a 8
mg/l. La campagna di monitoraggio effettuata a Firenze ha fornito numerose informazioni.
Dai risultati ottenuti si può dire che la maggiore
concentrazione dei metalli si ha nel centro cittadino. Tale concentrazione va da 6 a 8
mg/l. La campagna di monitoraggio effettuata a Firenze ha fornito numerose informazioni.
Si conferma quindi il monitoraggio biologico un metodo poco costoso ed efficiente per
scoprire il tipo di inquinanti presenti e quindi anche per sapere come agire e dove sugli
agenti inquinanti.
EFFETTI
DI ALTRI INQUINANTI
Da altri studi più specifici ( per quanto
riguarda le piante) è stato notato che l’anidride solforosa penetra nelle foglie
attraverso le aperture degli stomi e poi da qui trasmessa al resto del tessuto che
l’assorbe e dopo viene trasformata dalle cellule in acido solforico e solfiti e poi
ulteriormente ossidati a solfati , la forma nella quale lo zolfo viene metabolizzato dalle
piante. Le alterazioni da anidride solforosa si manifestano sulle foglie prevalentemente
sotto forma di decolorazione o imbrunimento dei tessuti.Per quanto riguarda gli effetti
sulla riproduzione , è stato rilevato che l’esposizione ad anidride solforosa nella
concentrazione di 0,3 ppm per un’ora inibisce la germinazione del polline e
l’accrescimento del tubetto pollinico (attraverso cui i gameti maschili raggiungono
quelli femminili per la fecondazione.La tolleranza all’anidride solforosa diminuisce
in presenza di umidità relativa elevata , di acqua sulle foglie, di alte temperature, di
intensa luminosità e di anzianità della pianta. L’inquinamento da biossido
d’azoto viene considerato, invece, di minore importanza in quanto generalmente
provoca danni alla vegetazione solo a livelli di concentrazione molto elevati rispetto a
quelli dell’anidride solforosa.
EFFETTI
DELL’INQUINAMENTO AEREO SUL TERRENO
Siccome le precipitazioni sono
costituite dall’acqua evaporata dal terreno, se il suolo è inquinato anche
l’acqua evaporata e quindi le piogge saranno inquinate. Tale inquinamento sarà
causato dai diserbanti , pesticidi e i vari concimi artificiali che vengono usati nel
settore primario, cioè nell’allevamento e nell’agricoltura, per migliorare il
raccolto sia in quantità che in qualità. Inoltre ci sono altri due tipi di sostanze
inquinanti che di per sé non sono pericolose ma che lo possono diventare dopo lungo tempo
dalla sua emissione nell’ambiente . Queste sostanze sono cloroderivati organici (
insetticidi ) che si accumulano nell’ambiente e anticrittogamici a base di composti
organici del mercurio. Le sostanze finora descritte possono contenere ioni cloruro,
manganese, cadmio, cobalto, zinco oppure composti alifatici ,fenolici e benzocarbossilici
(24%). Alcune volte possono contenere anche acidi aromatici e amminoacidi. Tutte queste
sostanze hanno una costante di stabilità più elevata a valori di pH uguali a 5 perciò
sarebbe opportuno lavorare in ambienti basici diminuendo quindi la stabilità di questi
ioni. Attraverso le piogge acide , gli inquinanti acidi arrivano al suolo e se il terreno
è ricco di carbonati l’apporto acido per tempi limitati non provoca danni in quanto
viene neutralizzato ma per tempi lunghi potrebbe esaurire la capacità del terreno di
mantenere costante il pH. In suoli poveri o privi di calcare ,gli inquinanti acidi
determinano modificazioni dello scambio cationico con perdita di ioni calcio, magnesio,
potassio e sodio e relativo impoverimento del terreno e con liberazione di ioni metallici
che possono essere tossici per le piante. In particolare un forte abbassamento del pH è
accompagnato dalla liberazione di composti tossici dell’alluminio.
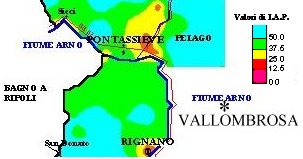 FIG.1:MAPPA DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEI PRESSI DELLA
FORESTA DI VALLOMBROSA - CD PROVINCIA
'99
FIG.1:MAPPA DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEI PRESSI DELLA
FORESTA DI VALLOMBROSA - CD PROVINCIA
'99