|
|
|
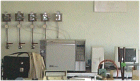 gascromatografo |
L'importanza di questa
determinazione analitica dei grassi è dovuta al fatto che da una sola procedura
analitica viene ricavata una notevole quantità di parametri; inoltre
questi parametri sono specifici, cioè corrispondono alla percentuale di
singoli componenti chimici presenti in un olio. La composizione acidica può rappresentare quindi un indice di genuinità e tipicità di un olio. L'analisi degli acidi grassi come esteri metilici viene eseguita con le metodiche al gascromatografo. |
| PRINCIPIO
Gli acidi grassi dei gliceridi presenti nell'olio vengono trasformati, mediante transesterificazione, nei rispettivi esteri metilici, che presentano una maggiore volatilità ed una minore polarità rispetto ai corrispondenti acidi liberi. Inoltre, con questa reazione, vengono decomposti i trigliceridi misti rendendo possibile il dosaggio dei singoli acidi che ne facevano parte. Gli acidi grassi metilati vengono iniettati in colonna e separati come tali. Ne segue che questa determinazione fornisce la composizione acidica in esteri metilici anzichè in acidi liberi. In pratica, la differenza tra le due composizioni è abbastanza piccola e comunque tutti i valori tabulati di riferimento sono basati sui metilati, quindi non si ha alcuna incertezza di attribuzione. L'identificazione dei singoli acidi avviene o mediante cromatogrammi eseguiti su standard e/o mediante il calcolo degli indici di ritenzione. Ma nell'analisi di routine, ferme restando le condizioni operative, sono sufficienti i tempi di ritenzione. Il calcolo delle percentuali dei singoli componenti viene effettuato col metodo della normalizzazione interna, in quanto tutti i componenti devono essere dosati. |
 |
| CONDIZIONI
OPERATIVE - colonna: fase stazionaria a polarità medio alta, come ad esempio il dietilenglicolsuccinato (DEGS); si possono usare sia colonne impaccate, sia capillari, sia wide bare, tenendo presente tuttavia che con le impaccate la separazione degli acidi arachico, eicosenoico e linolenico è spesso insufficiente (e quindi vengono dosati assieme). - temperatura della colonna: 190-200 °C. - temperatura dell'iniettore: 250 °C. T - temperatura del rivelatore: 250 °C. - gas di trasporto: elio, oppure azoto. ESECUZIONE DEL CROMATOGRAMMA La quantità di sostanza iniettata deve essere adeguata al tipo di colonna. In ogni caso deve essere tale da rendere dosabili (cioè nettamente distinguibili dal rumore di fondo) componenti presenti almeno sino allo 0,1%. Si attende che il registratore abbia tracciato tutto il cromatogramma. In genere, per gli oli di oliva, ciò avviene dopo l'uscita dell'acido eicosenoico (C20), ma se si hanno sospetti sulla genuinità dell'olio e bene protrarre l'acquisizione sino all'uscita dell'acido erucico (C22). |
 |
| ESPRESSIONE DEI RISULTATI
In un tipico referto di analisi GLC degli acidi grassi vengono riportati, per ciascun acido metilato: il tempo di ritenzione assoluto; il tempo di ritenzione relativo; l'area assoluta del picco; il fattore di risposta; la percentuale di acidi metilati. Il dato che interessa maggiormente è quest'ultimo, in quanto consente di caratterizzare l'olio in esame attraverso il confronto con i valori di riferimento. Il calcolo delle percentuali viene effettuato, in base alla misura delle aree dei picchi che vengono trasformate in concentrazioni secondo il metodo della normalizzazione interna. Per calcolare i fattori di risposta, si esegue un cromatogramma su una miscela, a composizione esattamente nota e vicina a quella in esame, di esteri metilici di acidi grassi. Data la notevole somiglianza che sussiste tra i vari componenti degli oli, questi fattori non si discostano molto dall'unità. |
 |
| INIZIO | |